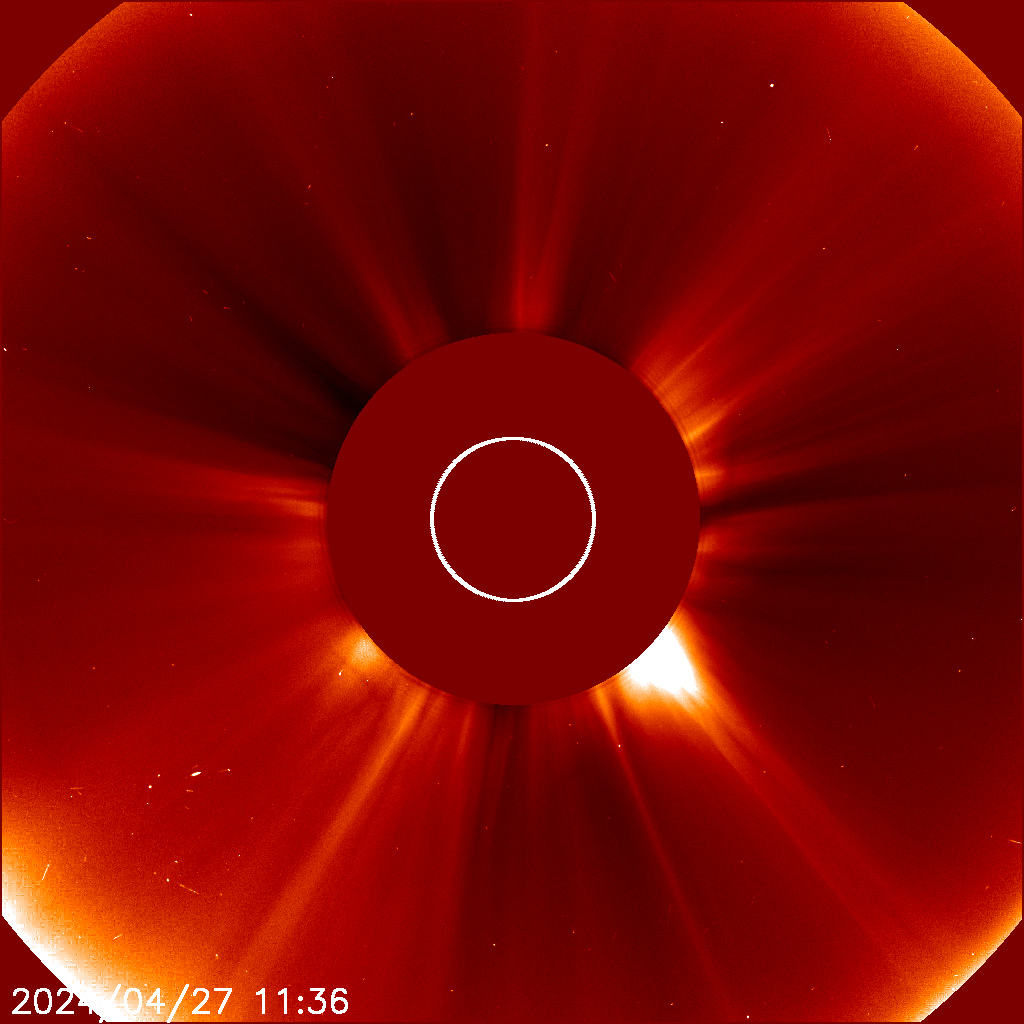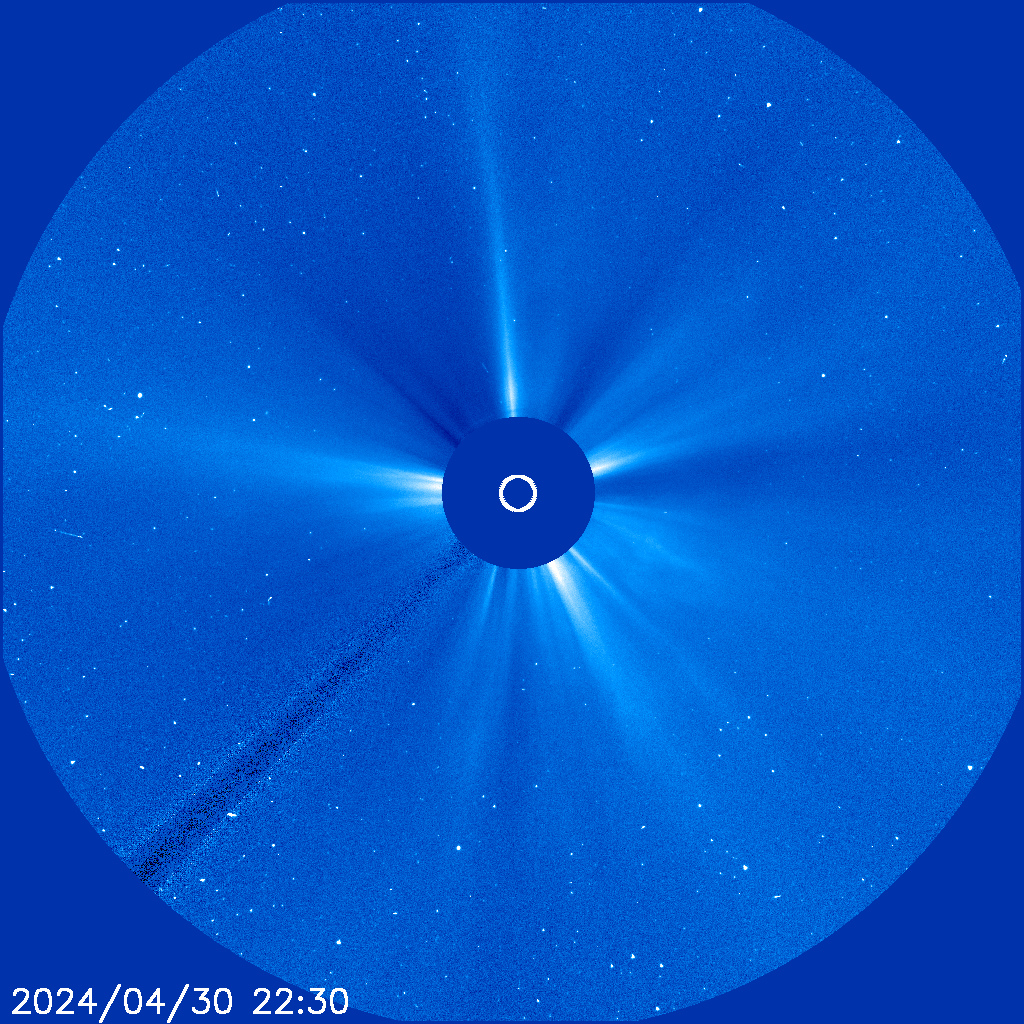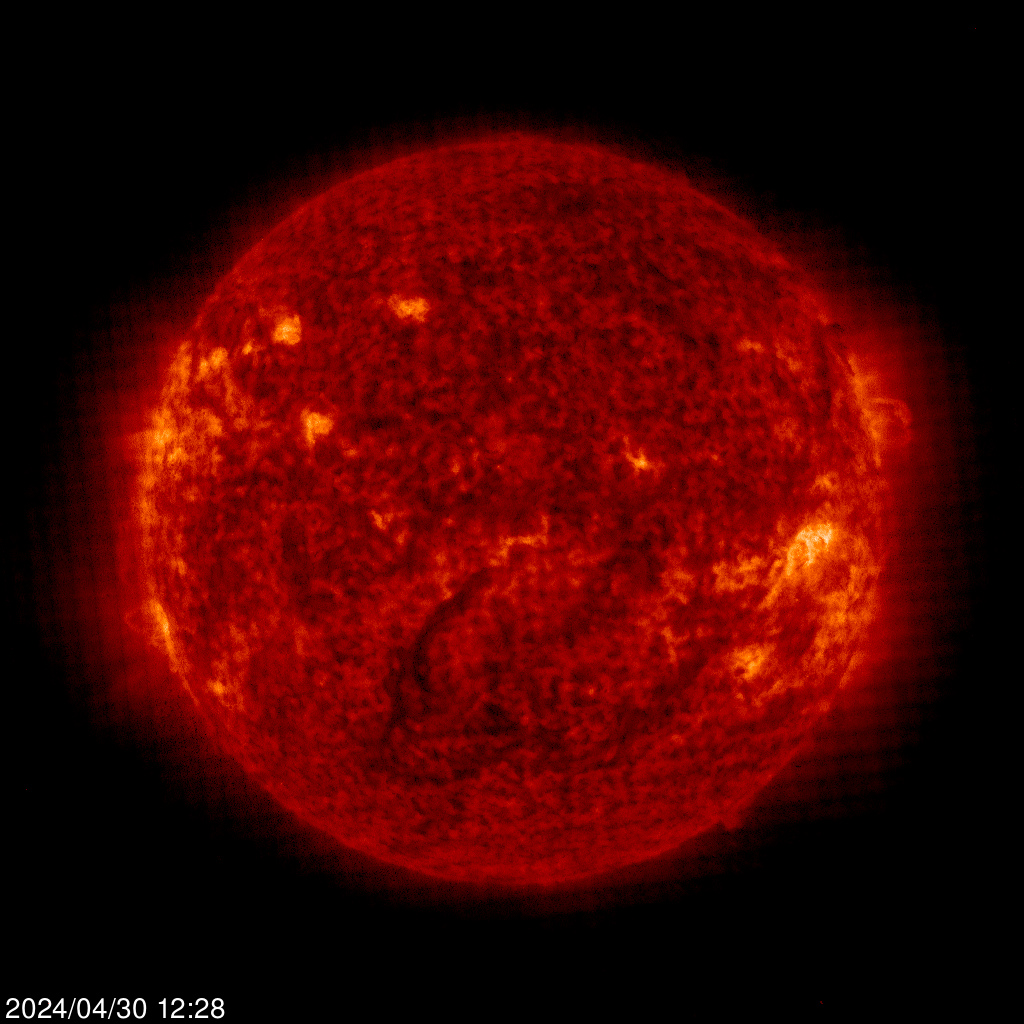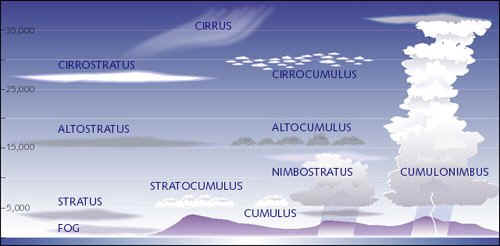Stelle
Osservando il cielo le stelle appaiono come migliaia di puntini luminosi, diversi per intensità, colore e dimensione, che si trovano stampati su di un'unica superficie a disegnare le più svariate forme. Sin dai tempi antichi infatti, nonostante esse occupino zone contigue del cielo solo per effetto prospettico, essendo distanti fra loro a volte per migliaia di anni luce, è stato possibile raggruppare le stelle più luminose in modo da formare quelle figure a cui si è dato il nome di costellazioni.
Le stelle si sono meritate inoltre nel corso dei secoli l'appellativo di fisse, anche se in effetti, al pari di tutti i corpi del sistema solare, esse si muovono (moto proprio), ma in maniera talmente lenta che per notare degli spostamenti bisognerebbe attendere millenni. Questo perchè, a differenza dei pianeti, esse si trovano ad una distanza talmente grande da rendere l'angolo che deriva dallo spostamento quasi impercettibile.

Magnitudine stellare
Le stelle si distinguono in base alla magnitudine relativa (luminosità apparente), una scala di valori centrata sullo zero, corrispondente al valore della stella Vega, con i valori più alti espressi con numeri negativi. La differenza fra le prime e le ultime è di circa 1 a 500, vale a dire che le stelle di magnitudine 1 saranno 500 volte più luminose di quelle dell'ultima classe (25).
Un'attenta valutazione va posta dunque alle distanze ed alle dimensioni stellari, che se non correttamente valutate possono portare a considerazioni errate. Il Sole infatti, una stella di medie dimensioni, che è anche la più vicina a noi (dista in media 149,6 milioni di chilometri, pari a 8 minuti luce), ci sembra ben più grande e luminoso di tante altre stelle, che pur emettendo luce per migliaia di volte tanto, appaiono molto deboli e minuscole a causa della loro lontananza.

| Nome | Costellazione | Distanza (A.L.) | Magnitudine |
|---|
Sirio Cane maggiore 8,6 - 1,4
Canopo Carena 312 - 0,7
Rigil Kentaurus Centauro 4,4 - 0,2
Arturo Bifolco 36,7 - 0,1
Vega Lira 25, 3 0
Capella Auriga 42,2 0,08
Rigel Orione 773 0,1
Procione Cane minore 11,4 0,3
Achernar Eridano 144 0,4
Betelgeuse Orione 427 0,5
Per ovviare a questo problema, e considerando che l'intensità della luce diminuisce col quadrato della distanza della sorgente, si usa allora la magnitudine assoluta (luminosità effettiva), ossia si considerano i corpi stellari come posti tutti alla stessa distanza, fissata per convenzione in 10 parsec, equivalenti a circa 32 anni luce.

Metodi per la misura delle distanze stellari
Per risalire alla distanza stellare un metodo molto usato è quello che sfrutta il fenomeno della parallasse annua. Infatti, considerando il nostro pianeta in un punto qualsiasi della sua orbita, e puntando da esso una stella x, dopo sei mesi, quando la Terra sarà in un punto esattamente opposto, si vedrà lo stesso astro spostato sullo sfondo celeste di un angolo che sarà tanto più piccolo quanto esso sarà distante da noi. Misurando dunque l'entità di tale angolo, e conoscendo il raggio dell'orbita terrestre, 1 U.A., dalla trigonometria avremo la distanza D = 1 : tgA espressa in parsec.

Tuttavia per le stelle più lontane, essendo l'angolo risultante talmente piccolo da non poter essere misurato, si usano altri metodi come quello spettroscopico o quello delle cefeidi.
Il primo consiste nello scomporre la luce della stella nelle sue componenti fondamentali facendola passare attraverso un prisma. Analizzandola si notano le bande colorate dello spettro che risultano separate da righe oscure, che non sono altro che assorbimenti da parte dei gas che compongono il corpo stellare. Da queste è dunque facile risalire alla composizione chimica ed alla magnitudine assoluta delle stelle, che poi posta a confronta con quella apparente ci darà la distanza.
Spesso si ricorre anche alle cefeidi, da Delta Cephei, la prima stella con queste proprietà ad essere stata scoperta, che hanno la caratteristica di variare in modo regolare la loro luminosità secondo un periodo ben determinato che è direttamente proporzionale alla stessa intensità luminosa. Dunque più lungo sarà questo periodo, maggiore risulterà la magnitudine assoluta, dalla quale otterremo poi quella apparente e quindi la distanza.
FONTE :
http://www.astrosurf.com/cosmoweb/files/header.gif